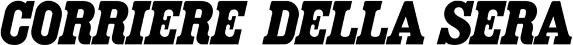Holot, non un villaggio turistico
di Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi - Domenica 14 Giugno 2015 ore 12:40
Milano, Roma nelle principali stazioni di transito italiane qualche centinaia di immigrati in cerca di una destinazione. Poche persone confrontate con il flusso di viaggiatori, pendolari e turisti in transito ma sufficienti a mostrare un problema, una situazione emergenziale che nasce non in Italia ma sulle sponde sud del Mediterraneo, in Medioriente, nell'Africa subsahariana. Guerre, carestie e disastri, arrivano da queste terre molti dei 50 milioni di rifugiati nel mondo secondo l'agenzia delle Nazione Unite, i dati sono dell'ufficio UNHCR.
Rifugiati, “protetti” da convenzioni internazionali, in fuga e a rischio della vita, arrivano lungo le nostre coste, sono richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti. Come gestirne il flusso? Alcuni stati introducono nuovi approcci e aprono la discussione, politica e morale. Sono risposte sufficienti? Oppure semplici palliativi?
Nel Medioriente dei conflitti in Israele si sta discutendo su come affrontare il destino dei 50mila immigrati clandestini entrati nel paese, prima che nel 2013 venisse “srotolato” lungo il confine con l'Egitto la barriera che oggi impedisce l’ingresso. Lo scorso anno 7mila sono stati rimpatriati, mentre solo 1.500 hanno deciso volontariamente di lasciare Israele per un paese terzo. Trasferire in massa gli immigrati in un paese africano, diverso da quello di provenienza, è la misura in discussione in questo momento a Gerusalemme.
Secondo quanto riportato dai media il precedente governo era pronto a finalizzare un accordo multimilionario con alcuni paesi africani, Rwanda e Uganda, dove espellere gli immigrati che avessero volontariamente deciso di lasciare Israele. Questioni politiche, umanitarie, morali ed economiche in questi giorni si intrecciano.
Nel frattempo, a Holot nel centro di detenzione più importante di Israele vivono circa 1500 immigrati in attesa di conoscere il proprio futuro. Per arrivare ad Holot da Gerusalemme ci vogliono quasi tre ore di viaggio. Passando le verdi colline dei vigneti di Latrun. Lasciando in lontananza le città di Ashdod, Gaza ed infine Beer Sheva si attraversa il deserto del Neghev con le dune di sabbia rossastra. Lungo la strada n. 40 il paesaggio è movimentato dai villaggi beduini, dai verdi kibbutzim e dalle tende da campo dei soldati in addestramento.
Imboccata la numero 211 i carri armati in manovra sulle dune alzano nuvole di sabbia. Il lungo reticolato perimetrale di Holot è a pochi metri da quello della prigione di Saharonim. Al suo interno ben visibili blocchi numerati, edifici ad un solo piano, la biancheria al sole. L'ingresso all'interno del centro è vietato alla stampa. Intervistiamo Nicole Englander, portavoce del governo, ci dice che “ogni modulo abitativo con aria condizionata può ospitare fino ad un massimo di 10 persone, nel centro ci sono negozi e cliniche mediche, biblioteca e caffetteria”.
Ma Holot visto da fuori non è un villaggio turistico, tutt'altro: è una “prigione aperta” per soli uomini. L’ingresso principale è una grande volta sopra un cancello, a lato un piccolo edificio con due porte, tra queste un distributore di bevande, in alto la bandiera d’Israele. I tornelli ruotano in continuazione, al passaggio degli immigrati. Alla vicina fermata del bus la pensilina con il cartello indica solo tre destinazioni, la più vicina è il villaggio di Nizzan, la più lontana la città di Beer Sheva. Il personale che ha terminato il turno di servizio è in coda per salire sul bus numero 44. Alla vista della macchina fotografica alcuni immigrati preferiscono non farsi riprendere, altri non vogliono parlare.
Sono di provenienza eritrea o sudanese. Come Adam e Faisal, vengono dal Darfur, 39 anni il primo e 32 il secondo, salutano in ebraico per poi parlare in perfetto inglese, sono arrivati nel centro a marzo del 2013. Raccontano la loro storia, il tentativo di giungere in Italia dalla Libia, dove hanno soggiornato a lungo, fermati dalla paura del mare e dalle tariffe elevate degli scafisti. Allora, hanno intrapreso la via delle carovane della morte, pagando mille dollari per raggiungere la Terra Santa. Sono sfiduciati, nel campo si annoiano e l'unico svago è praticare sport, nei loro volti rassegnati c’è dignità. Nel piazzale antistante l'ingresso rottami, auto dismesse, bottiglie accatastate sono sparse ovunque.
Tende e ombrelloni colorano l'ambiente. Alcuni giovani africani preparano i narghilè mentre altri sbucciano frutta o tagliano verdure. E’ il convivio dei migranti, un suk polveroso e scarno. “A Holot ciascun immigrato riceve un sussidio giornaliero di 16 shekels, meno di 4 €, servono per le spese personali” come tiene a precisare Nicole. Mohamed non vuole essere fotografato, racconta che a Tripoli non ha avuto il coraggio d'imbarcarsi, cosa che invece ha fatto il suo amico fraterno ora in Italia. Oggi è pentito, però non è disposto ad accettare, in cambio di denaro e visto, la destinazione per un paese africano.
Scuote la testa e aggiunge: “Io resterò, altrimenti tornerò a casa, se proprio devo morire voglio farlo nella mia terra”. Israele nella sua storia ha dato asilo a gente proveniente da tanti paesi, persino dal Vietnam e più recentemente dal Nepal. Oggi si chiede cosa fare dei migranti africani: se regolarizzarli diventando così forza lavoro e chiudendo luoghi come Holot, oppure procedere con le espulsioni. L’Italia come l’Europa deve avere il coraggio di porsi la stessa domanda sapendo che i flussi migratori non si fermano. Con questo fenomeno dobbiamo convivere.
Leggi anche su www.ilmedioriente.it
Alfredo De Girolamo e Enrico Catassi